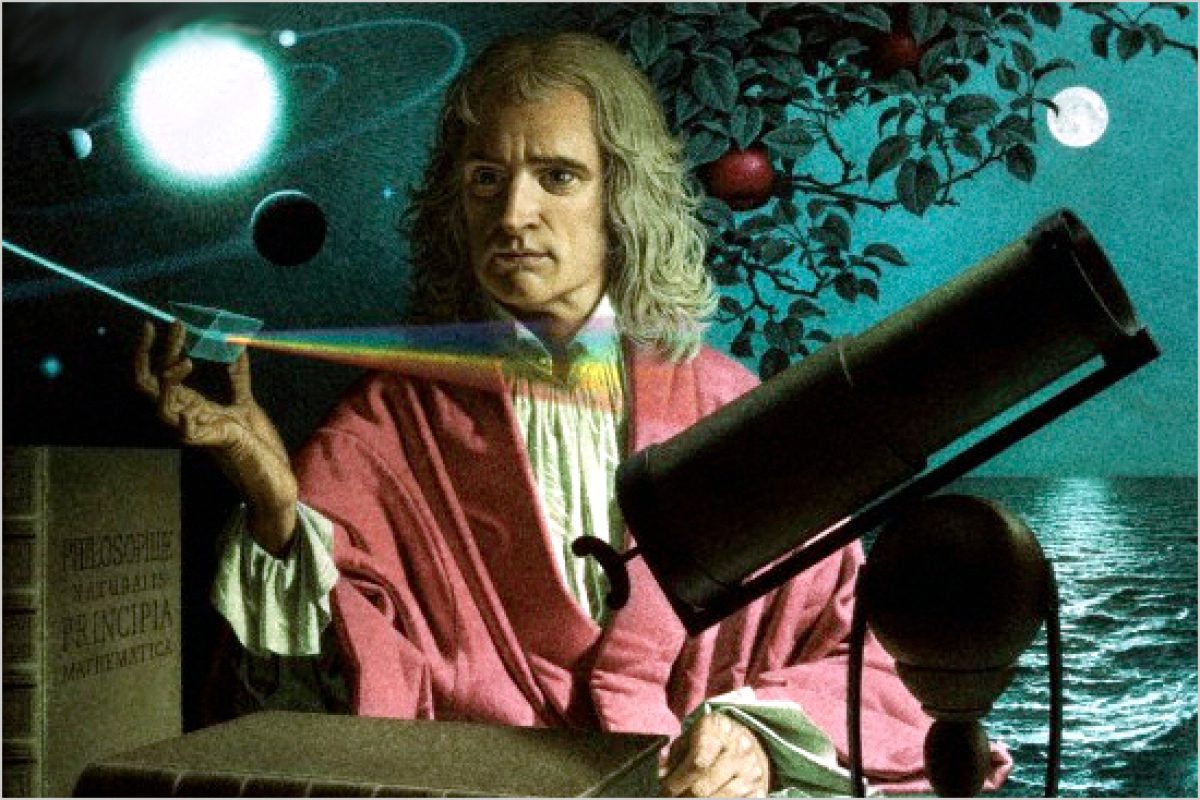Havvi, cosa strana a dirsi, un disprezzo della morte e un coraggio più abbietto e più disprezzabile che la paura: ed è quello de’ negozianti ed altri uomini dediti a far danari, che spessissime volte, per guadagni anche minimi, e per sordidi risparmi, ostinatamente ricusano cautele e provvidenze necessarie alla loro conservazione, e si mettono a pericoli estremi, dove non di rado, eroi vili, periscono con morte vituperata. Di quest’obbrobrioso coraggio si sono veduti esempi insigni, non senza seguirne danni e stragi de’ popoli innocenti, nell’occasione della peste, chiamata più volentieri cholera morbus, che ha flagellata la specie umana in questi ultimi anni.
[G. Leopardi, Pensieri VII, 1845]
Sarà che del coronavirus si fa e si è fatto un gran parlare tanto da aver ormai monopolizzato il nostro attuale immaginario per un tempo che sarà complicato stimare breve ma tant’è che leggendo (o rileggendo) questo “pensiero” leopardiano di quasi due secoli fa è impossibile non venire trasportati nel nostro contingente e, in particolare, in quello che riguarda le modalità della gestione dell’emergenza e del post-emergenza. I “Pensieri” di Leopardi, appaiono postumi nel 1845, ordinati e scelti, però, da lui stesso col fine di esprimere una raccolta di considerazioni “sui caratteri degli uomini e sulla loro condotta in Società”. Duplice la natura degli estratti: da un lato un distillato, rivisto e corretto, del laboratorio zibaldoniano, dall’altro un gruppo di inediti lucidi e “glaciali” come ebbe a definirli Sergio Solmi capaci di elevarsi dal particolare all’universale sulla scia di quella vena aforismatica e polemica che aveva trovato nel periodo a cavallo tra Sei e Settecento la sua età dell’oro. Relativamente al pensiero riportato già un vecchio commentatore dell’opera, il Siebert (per l’edizione critica in lingua tedesca de “I pensieri” del 1896), rinviava a un frammento euripideo citato da Seneca ovvero:
“Avari hominis vox est, qui etiam vitam lucro postponit”
che, più o meno, in italiano suona così: “la vocazione dell’avaro è quella di anteporre il profitto alla vita”, focalizzando l’attenzione su quello che, per Leopardi (e non solo) è un mondo alla rovescia, un mondo degenerato, in cui le ragioni del profitto vengono, non solo contrapposte, a quelle della salute pubblica, ma addirittura poste avanti. Il serrato uso delle coppie ossimoriche “eroi/vili”, “coraggio/abbietto” rinvia a questa concezione di mondo “storto” che Leopardi aveva sperimentato direttamente con riferimento all’epidemia di colera (di cui accenna in una lettera a Monaldo del dicembre 1836) che, scoppiata in Francia nel ’32, era apparsa poi in Italia con le criticità che tutti sappiamo del biennio ’36-’37 a Napoli dove il marchigiano, dal 1833, risiedeva. Tema molto sentito questo in Leopardi delle pene e dei mali che affliggono l’umana natura aggravati dagli sconsiderati comportamenti dell’uomo e che ricorreva nel 1835 nella “Palinodia al marchese Gino Capponi”, componimento satirico in endecasillabi che deride le “magnifiche sorti e progressive” del secolo più fiducioso di tutti, l’Ottocento:
“Universale amore, / Ferrate vie, moltiplici commerci, / Vapor, tipi e choléra i più divisi / Popoli e climi stringeranno insieme” (vv. 42-5)
A cui fa eco quanto scritto già nel finale del Pensiero I, in cui Leopardi pone l’accento oltre che sull’immutabilità dei comportamenti e dei mali umani anche sul rifiuto di chiamarli col proprio nome e di farsene carico per volgerli al bene:
“(..) Anche sogliono essere odiatissimi i buoni e i generosi perché ordinariamente sono sinceri, e chiamano le cose coi loro nomi. Colpa non perdonata dal genere umano, il quale non odia mai tanto chi fa male, né il male stesso, quanto chi lo nomina. In modo che più volte, mentre chi fa male ottiene ricchezze, onori e potenza, chi lo nomina è strascinato in su i patiboli; essendo gli uomini prontissimi a sofferire o dagli altri o dal cielo qualunque cosa, purchè in parole ne sieno salvi”.
L’eterno dissidio tra tutela della salute pubblica di fronte al manifestarsi di un fenomeno pandemico e quello della garanzia di continuità del profitto privato che ogni governo dei popoli è chiamato ad affrontare, ritornando ai giorni nostri, è di nuovo esploso in termini drammatici con accuse da più parti all’indirizzo dell’esecutivo da un lato di non essersi adoperato a sufficienza per arginare tempestivamente i rapidi focolai in espansione e, dall’altro, di aver impedito a tante piccole attività commerciali, industriali, ecc. giudicate di non rilevanza strategica di poter restare aperte. Un esempio su tutti per la natura paradigmatica del fenomeno e di quanto finora detto è l’inchiesta portata avanti dalla Procura di Bergamo sulla mancata istituzione, da parte del governo, delle cosiddette “zone rosse” ad Alzano e Nembro due grossi epicentri del contagio covid-19 e che sta vedendo un rimpallo di colpe tra Regione Lombardia e governo centrale per il quale gli inquirenti hanno ritenuto opportuno ascoltare le testimonianze di Conte, Speranza e Lamorgese. Qui non è il caso di ripercorrere tutte le tappe del contagio e dei provvedimenti presi tra il 21 e il 23 febbraio a partire da Codogno (Lodi) o da Vo’ (Padova) ma è bene rimarcare come in Val Seriana questa “solerzia” e tempestività non si siano assolutamente manifestate. Già il 26 febbraio, infatti, le mancate cautele causavano i primi 20 casi di contagio nella provincia di Bergamo con i 508 casi certificati al 2 marzo e nonostante politici e confindustrie (nazionali e locali) facessero di tutto per ridimensionare il fenomeno. Nonostante le note dell’ ISS che consigliavano la chiusura della Val Seriana (area ad elevatissima densità industriale, uno dei cuori pulsanti del manifatturiero italiano), Gallera temporeggiava e gli altri a Milano, Bergamo, Roma non erano da meno per le evidenti pressioni economiche. Quando, tra il 7 e l’8 marzo esercito e compagnia bella era pronto a chiudere tutto, ecco che si inizia a parlare, per queste e altre 14 province di “zone arancioni” (quindi a restrizioni molto inferiori alle “rosse”) fino a che, nelle successive ore tutto precipita e col primo Dpcm del 9 marzo tutta l’Italia viene trasformata in “zona protetta”. Contagiati e morti però esplodevano e regalavano alla provincia di Bergamo il triste primato di mortalità e di casi accertati. Nonostante l’inchiesta, al momento, non abbia indagati, sarebbe bene che si facesse luce su cosa non è andato in Val Seriana rispetto al lodigiano e al padovano e sulle responsabilità occorse. Resta però più di un dubbio, e qui chiudiamo, sull’effetto devastante per la vita della fascia di popolazione più debole delle pressioni ricevute dagli amministratori per ritardare il lockdown o comunque limitarne al minimo gli effetti sulla produzione da parte dei locali potenti capitani d’industria.