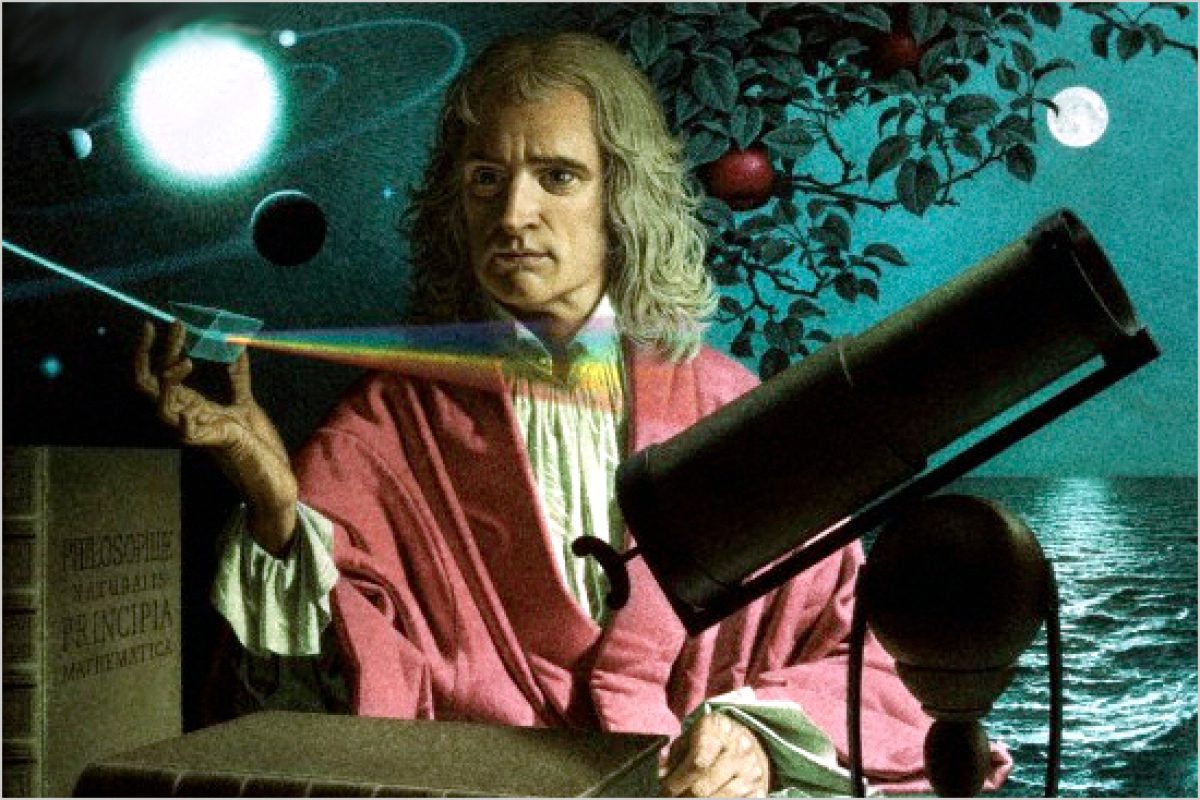Notava argutamente Masolino D’Amico come il romanzo borghese non fosse originato a partire da una costola di altri generi letterari per opera di giovani e illuminati sperimentatori bensì avesse dalla propria la natura di tardiva e quasi casuale “scoperta” da parte di due mestieranti, non proprio di primo pelo, prestati alla letteratura. I due sopra citati erano Daniel Defoe, avventuriero arrischiato e imprenditore votato (quasi) sempre alla bancarotta, che amava ispirarsi a storie vere per ricamarci sopra quelle esperienze verosimili tra marinai, pirati, colonnelli, prostitute, grassatori che il nascente pubblico popolare chiedeva a gran voce e che troverà il successo con “Robinson Crusoe” (1719); e Samuel Richardson, figlio di un falegname (di un macellaio, Defoe) del Derbyshire, autodidatta e impiegato prima come tipografo poi come redattore nella nascente bolla della stampa periodica, tuttavia scrittore ma pur sempre d’occasione. Sul modello delle famose “Lettere portoghesi” (1669) indirizzate da una monaca ad un suo ardente spasimante e delle “Eroidi” ovidiane, Richardson sfonderà nel mondo letterario con il romanzo epistolare “Pamela” (1740-41) grazie a pochi ma ben calibrati ingredienti: realismo della vicenda (una servetta insidiata da un gaudente nobile che riesce a volgere, dopotutto, a proprio favore le volgari proposte e, armata di ferrea virtù e specchiata moralità, finirà col convertire il reprobo riscattando inoltre la propria umile condizione), descrizione della vita delle classi sociali meno elevate, esibizione dei debiti nei confronti della comédie larmoyante allora ancora in voga e con un’illustre tradizione, morale edificante che faceva l’occhiolino al puritanesimo, narrazione fatta di equivoci, colpi di scena, avventure rocambolesche che, nonostante la mole dell’opera, se si supera l’impatto iniziale, permette addirittura di portare a termine la lettura integrale del testo. Fu così che “Pamela” divenne subito un bestseller. Basti pensare che, uscito anonimo in due volumi sul finire del 1740, ebbe, solo l’anno seguente, ben quattro ristampe; il suo successo venne poi rilanciato indirettamente da critiche, sequels apocrifi e parodie tra cui la più famosa fu senza dubbio quella di Henry Fielding con “Shamela” dove il seduttore B. diventò Mr. Booby (“booby” è gonzo in inglese), vittima di Pamela a sua volta trasformata in scaltra ammaliatrice e donna di più che dubbia moralità e con “Joseph Andrews” fratello casto della protagonista, insidiato dalla padrona con un rovesciamento eroicomico rispetto alle avventure originarie. I romanzi di Fileding e Smollett che, come suggeriva Charles Lamb, provengono direttamente dalla pittura di Hogarth così come quelli di Richardson, per accuratezza di rifinitura, dai pittori seicentisti olandesi, picareschi e dal gusto scenico (Fielding non a caso proveniva dal mondo del teatro) vengono a costituire l’altra tradizione letteraria all’interno del canone borghese settecentesco e poi ottocentesco: da un lato chi punta sull’intreccio (Smollett, Dickens, Fielding) e sul suo annullamento (Sterne prima, fino a Joyce e Woolf come epigoni novecenteschi), dall’altro chi punta sulla scarnificazione della trama in favore di uno spiccato psicologismo e della resa letteraria dei sentimenti (Richardson, appunto, per finire con Henry James). L’esistenza di questi due distinti filoni letterari non dovrebbe però far sì che si perda d’occhio il genere autonomo e ben codificato entro cui si muove “Pamela” prima e “Clarissa” poi del Richardson, ovvero il romanzo epistolare naturalizzatosi in Inghilterra già a metà Seicento con le già menzionate “Lettere portoghesi” e con la traduzione (1713) del carteggio tra Abelardo ed Eloisa, entrambe di provenienza francese. In Inghilterra, però, le raccolte epistolari assumono tratti peculiari: un tono più informale e di maggiore verosimiglianza con digressioni a fini di atmosfera, uno stile spesso quasi sciatto o lacunoso per offrire l’impressione di un ritrovamento casuale e incompleto, un gusto di derivazione teatrale per gli eccessi sentimentali, un’esposizione dei fatti non rispettosa della linearità temporale. Influenzato solo in parte da questa produzione, omogenea sì ma ritenuta minore, il genio di Richardson riuscì a trovare una sintesi unitaria in tale marasma raccordando le varie innovazioni e ponendole al servizio del fine di istruire e di tessere le lodi delle virtù moralizzatrici, quelle stesse virtù che la nuova classe egemone non avrebbe dovuto perdere di vista nella sua vasta e deliberata operazione di scalzamento sociale della vecchia aristocrazia. A ciò si aggiunga un indirizzo, per l’epoca sconvolgente, di “Pamela”: l’affermazione della possibilità di pareggio, all’interno della guerra dei sessi,come dimostrato dalla sedicente eroina che ribalta una situazione a lei totalmente sfavorevole facendo capitolare il libertino conte di Belfart e così salvando, per così dire, capra e cavoli. Un tale messaggio “anticonformista” poteva apparire all’epoca (e lo è ancora oggi) di insopportabile falsità e stucchevolezza (abbiamo già riportato delle risposte letterarie al fenomeno “Pamela”) tale cioè da sconfinare nella telenovela (per fortuna il lieto fine sarà eliminato nella successiva “Clarissa” del 1748). Il peggio, però, è nella tesi di fondo contenuta ovvero che il buon esempio avrebbe ottima efficacia suicattivi redimendoli. La virtuosa Pamela, incarnazione di bontà e morigeratezza, affetto filiale e fedeltà amicale, è un ciclone di buoni sentimenti che tutti travolge e tutti contagia fino al grottesco parodico e all’esibita volgarità (“vulgarity” in inglese è “ordinarietà” nel senso di merce a buon mercato) della lacrima a comando. Questo però non toglie il merito di Richardson: aver portato alla ribalta gusti, aspirazioni, sentimenti di una donna della working class impegnata in una dura guerra per conservare la proprietà di decidere del e sul proprio corpo al cospetto di un mondo che le nega ogni diritto (in quanto serva non può disporre di nulla senza il beneplacito del proprio padrone)il tutto nella parzialità del suo unico ed esclusivo punto di vista. Qual è oggi, allora, l’approccio corretto di fronte ad un polpettone come questo? Senza dubbio, quellodi lady Mary Wortley Montagu quando in una lettera del 22 settembre 1755 scriveva: <<Questo Richardson è uno strano tipo. Lo disprezzo cordialmente e lo leggo con avidità, anzi, singhiozzo sulle sue opere nel modo più scandaloso>>. Magnetico. // Nell’immagine adattamento tetarle da Luca Ronconi de “La serva amorosa” di Carlo Goldoni
Mese: novembre 2020
Un Lazarillo de Tormes tra le maglie della macchina burocratica fascista / “Vedrò Singapore?” – Piero Chiara
Un ingrato destino ha voluto che di Piero Chiara, oggi, se ne senta parlare solo (di riflesso, magari) tra gli addetti ai lavori e gli specialisti del secondo Novecento italiano, relegando il grande scrittore luinese nel ristretto novero dei cosiddetti “scrittori per scrittori”. Non sta a noi indagare le ragioni di tale oblio, di cui siamo stati noi stessi vittime prima che un fortunoso rinvenimento in un polveroso scaffale bibliotecario ci disvelasse l’esistenza di un autore a suo tempo vero e proprio fenomeno di massa anche grazie a celebri trasposizioni cinematografiche tratte dalle sue opere, ma è nostro compito, certamente, tentare, in questa infinitesima sede, di apportare un minuscolo contributo al ripescaggio di un grande indagatore della provincia italiana nei due fittissimi decenni costituiti dagli anni Sessanta e Settanta. Ma andiamo con ordine e, misconosciuti ai più, cominciamo con l’offrire dei brevi cenni biografici su Chiara, nativo di Luino (area Lago Maggiore, provincia di Varese) nell’anno 1913, da padre siciliano di professione doganiere e da madre piemontese piccola esercente di ceste ed ombrelli. Irrequieto e indisciplinato, Piero Chiara compie con alterne fasi i propri doveri di studente riservandosi un approfondimento da autodidatta per quanto riguarda la letteratura e viaggiando molto, tra Francia e Italia, tra svariati e saltuari lavori e intense frequentazioni fino, accontentando le richieste dei genitori, ad impiegarsi, sul finire del ’32, come aiutante di cancelleria nella pretura di Pontebba, al confine tra Alpi Carniche e Giulie, nella Val Canale, tra l’allora Regno d’Italia, l’Austria e il Regno di Jugoslavia, per poi finire trasferito ad Aidussina (oggi,Ajdovscina, di poco, Slovenia) e poi Cividale del Friuli. Colto in flagrante in approccio amoroso con un’amante sul luogo di lavoro, dopo diversi mesi di aspettativa, si ritrova trasferito nella sua Varese dove inizia a collaborare con riviste letterarie e contrae un fulmineo matrimonio. Nel ’44 deve riparare in Svizzera a seguito di un ordine di cattura del Tribunale Supremo fascista per un gesto politico di irriverenza. Poi, dopo la guerra, il ritorno e l’inizio di un’intensa attività letteraria il cui apice sarà raggiunto con “La stanza del vescovo” (1976) da cui Dino Risi trarrà anche un celebre film con Ugo Tognazzi nel ruolo di un patetico e malinconico piccolo borghese, replicato qualche anno dopo l’altro noto adattamento da Chiara, dal romanzo “La spartizione” (1964) di Alberto Lattuada con “Venga a prendere il caffè da noi” (1970). Piero Chiara muore nella sua Varese il 31 dicembre 1986 ricordato con l’istituzione, dopo pochi anni, di un prestigioso premio letterario a lui dedicato. // Il romanzo di cui parliamo oggi è “Vedrò Singapore?” (1981), opera matura intrisa di un evidente autobiografismo nel ripercorrere le vicende di un modesto impiegato dell’amministrazione giudiziaria italiana degli anni Trenta inviato al confine italo-jugoslavo tra aporie, inefficienze, crisi esistenziali, disinganni, atmosfere plumbee e repressive (incarnate dal fantomatico e ubiquo Alto Commissario Speciale per la Giustizia tal Gennaro Mordace), calcoli di infimo cabotaggio della profonda provincia impiegatizia (e non) di quell’epoca. Un po’ inetto sveviano (senza però le nevrosi e gli psicologismi del noto triestino) un po’ vitellone attratto dal buon bere, dal gioco delle carte e dalle conquiste femminili, il protagonista, per il tramite dell’arguta, ironica e malinconica penna di Chiara, compie la sua iniziazione alla vita, alla politica (sposerà, grazie a temporanei ma intensi incontri, un blando antifascismo), alla sessualità, ai travagli dell’etica (col tentativo di “salvare” la cassiera del Caffè Longobardo di Cividale, Ilde, dalla promettente carriera di meretricio) in una picaresca sarabanda di colpi di scena al termine dei quali otterrà finalmente soddisfazione dalle angherie subite dal terribile Mordace ma dovrà rinunciare al proprio stipendio sicuro in attesa di imbarcarsi sul mercantile “Adelaide Tarabocchi”, pronto a toccare i più che esotici porti di Porto Said, Suez, Bombay, Colombo e… la Singapore del titolo. Prima, chissà, della possibilità, per lui, di tornare “alle onde del Lago Maggiore” in un afflato nostalgico degno del miglior Renzo Tramaglino. // La scrittura di Piero Chiara, dotata di pazienza metodica e di lieve grazia d’altri tempi, restituisce nei suoi vividi colori il grigio quadro della provincia fascista e della sua umanità in attesa dell’atto finale della recita del regime, deprecando sommessamente la rinuncia alla vita e le pulsioni statiche degli sfiduciati a vita, col punto di vista di un moderno Lazarillo de Tormes (non citiamo a caso visto che Chiara era un grande estimatore dell’opera) dall’insaziabile sete di vita e avventure e immune alle costrizioni morali, sociali e politiche. In questo periodo di chiusure forzate causa covid, futuro incerto nella cornice di un presente atono e claustrofobico, obbligata rinuncia a mobilità e socializzazione, un romanzo capace di farci scorrazzare in lungo e in largo nei tempestosi mari del Sud, tra loschi pirati in giacca e cravatta, ambigue e ciniche vivandiere, affidabilissimi antieroi, il tutto stando comodamente seduti in poltrona.
Vedrò Singapore? – Piero Chiara – Mondadori 2013 – XLIII, 193 pag. – 10,00 €