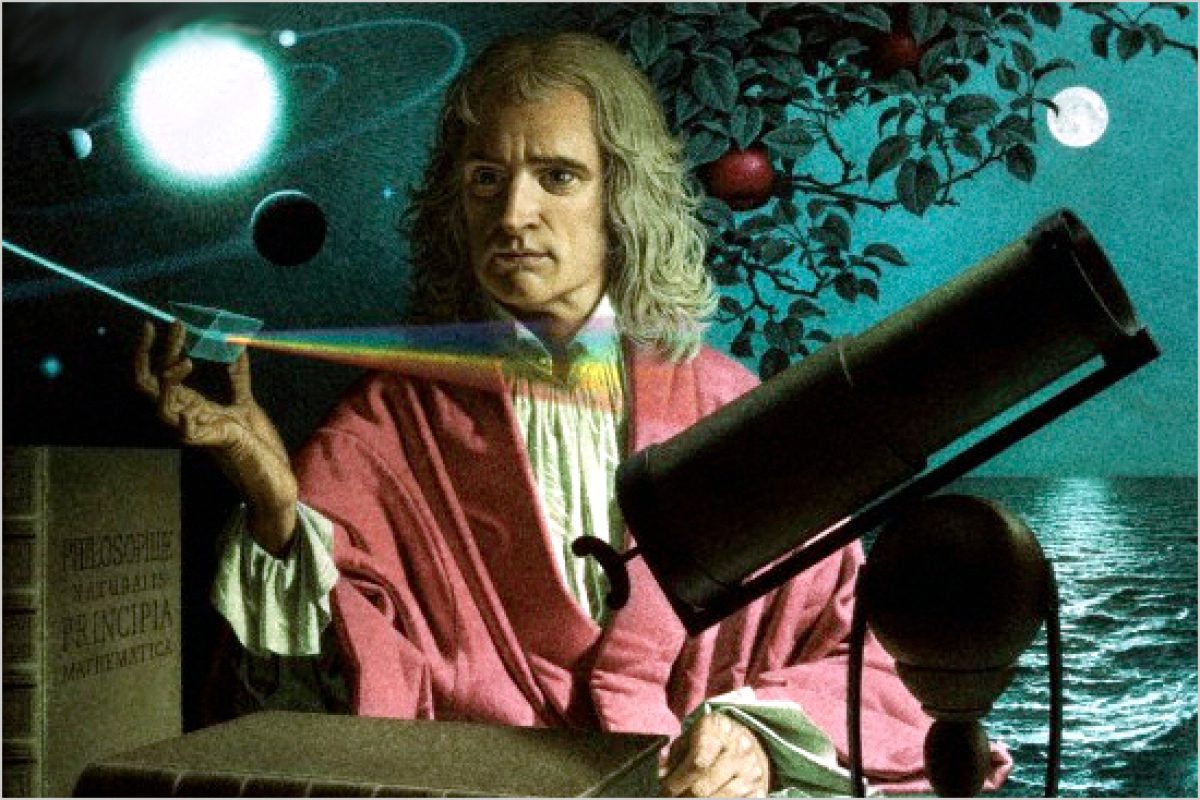Due fratelli, contraddistinti ognuno a suo modo da una vena al fulmicotone, insieme a un corollario di personaggi secondari strampalati e spassosi, sono i protagonisti di questa opera del 1973 di Bohumil Hrabal, la seconda in ordine di pubblicazione all’interno della trilogia del cosiddetto “ciclo di Nymburk” iniziata con “La tonsura” e conclusa con “I milioni di Arlecchino”. Narratore è qui un Hrabal bambino/adolescente, osservatore acuto e fedele trascrittore (è importante sottolineare come egli si sia sempre definito appunto trascrittore e non scrittore) della vertiginosa sarabanda della cittadina alle porte di Praga (dove l’orologio del campanile ha da tempo smesso di compiere il proprio dovere), innescata da papà Franzin e da zio Pepin, ennesime declinazioni della figura del pàbitel (traducibile in italiano con “parabolano”, “gradasso” o “stramparlone”), maschera onnipresente nel “teatro” hrabaliano e attivatrice del meccanismo del “realismo totale” che ha reso la prosa del ceco famosa nel mondo. Una “fattografia”, un resoconto di fatti “reali” affidata al flusso di ricordi, caotici, ricchi di iperboli, ridondanze ed esagerazioni, che formano le miriadi di frammenti con cui viene riassemblato un passato sotto forma di eventi né del tutto veritieri né del tutto inventati, con il ricorso ad un surrealismo “spontaneo” dal linguaggio mutuato dall’oralità e come tale rimaneggiato, gergale, inaffidabile nella ricostruzione del vero. Un racconto però montato da un letterato colto in grado di elevare il parlato comune a rare vette liriche e letterarie, uno spettatore perennemente in bilico tra amore e scetticismo, malinconia e poesia.
La forza di Hrabal non è nella pretesa di voler capire e interpretare la vita fornendo chiavi definitive, ma nel voler solo occuparsi di raccontare, come una Sherazade, costruendo un insieme infaticabile di immagini e di piani narrativi (che ricordano i piani-sequenza della cinematografia) con cui fermare e ingannare il tempo. Nella “Cittadina”, infatti, H. ha bisogno, per raccontare la propria infanzia e l’adolescenza, di bloccare il fluire delle lancette dell’orologio con la tecnica del “ricordo che si fa racconto” e che quindi ricostruisce a posteriori una nuova realtà sulla base del vecchio mondo, ridonando nuova vita alla cittadina scomparsa con il passaggio alla dimensione mitica, dell’eternità che si ripete senza sosta. L’epica di Nymburk può così rivivere solo nei ricordi sfumati e indefiniti di un narratore che rimette in moto la vita del villaggio tramite aneddoti, spacconate, bevute e litigi colossali, che hanno il compito ognuno di fissare sullo sfondo un “carattere” appartenente a quel mondo ormai cancellato dalla Storia. Ecco che, dal buio del tempo, tramite il fluire continuo della lingua e delle sue varianti gergali, dialettali, militari, burocratiche, ecc., emergono le figure di zio Pepin che “come diceva la mamma, era venuto da noi otto anni fa per una visita di due settimane ed era tuttora con noi”, donnaiolo, bevitore e ballerino provetto dall’inseparabile cappello bianco da capitano di marina, il quale si muove nel romanzo come un debordante folletto combinaguai; del fratello Franzin, amministratore del locale birrificio, e diverso in tutto dall’agitato fratello ovvero calmo, misurato, praticamente astemio e immune dal fascino femminile ma con l’incredibile mania dello smontaggio delle parti meccaniche di moto e autoveicoli, operazione che compie tentando di coinvolgere nella manodopera parenti, vicini e colleghi tutti terrorizzati dalla titanica e interminabile impresa (vero pezzo da manuale di comicità è lo smembramento della Skoda 430 che “papà smontava solo per capire perché quella macchina funzionava in maniera così precisa, perché partiva, marciava così perfettamente, che per quanto era perfetta papà non ci dormiva”) ; della moglie del macellaio, la signora Bùrytkova, con la pessima abitudine di bere smodatamente e, contestualmente, di spogliarsi tutta davanti agli estranei; degli operai del birrificio che, con la nazionalizzazione, parlano con un’unica voce ripetendo gli slogan di regime e così via.
L’orgia paratattica della scrittura hrabaliana tiene assieme ogni registro: il comico, il lirico, il tragico, come egli scrive nella postfazione, “in modo spontaneo, per direttissima, e anche qui [come nel “Re”] ho solo cancellato”: la realtà di H. si costruisce per sottrazione , è formata da pochi elementi visivi che attraversano il tempo e concorrono alla ricostruzione complessiva del quadro; è nel flusso continuo e tra le sue pause (dettate dai ritmi della respirazione e non dalla scarsissima punteggiatura, come ci fa notare la traduttrice) che vanno scovati gli “oggetti” a-temporali che fissano la narrazione. Come ad esempio il berretto bianco di zio Pepin, “il simbolo dei vecchi tempi d’oro, e non solo per lo zio Pepin ma anche per papà”. Quel berretto che nella scena finale sarà lanciato al vento e, planato sull’acqua, trascinato via dalla corrente. Immagine che, per associazione, allude alla contemporanea morte nell’ospizio di Pepin che non viene raccontata ma solo lasciata intuire dall’allontanarsi dell’inseparabile copricapo che si perde alla vista. Un piccolo-grande libro da cui, chi è ancora a digiuno dell’opera di H., può iniziare a orientarsi nella sua vasta ed eterogenea produzione, dove pagine esilaranti si alternano ad altre di rara e toccante tristezza (specie nel finale e passando per la suspense a seguito della repressione per l’attentato mortale al Reichsmaresciall Heydrich) e dove l’improvviso e duraturo stop dell’orologio cittadino crea una “condizione di grazia” per lo sviluppo di un pezzo di grande letteratura.
La cittadina dove il tempo si è fermato – Bohumil Hrabal – e/o coll. praghese – 2014, 153 pag. – 17,00 €